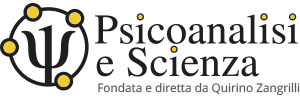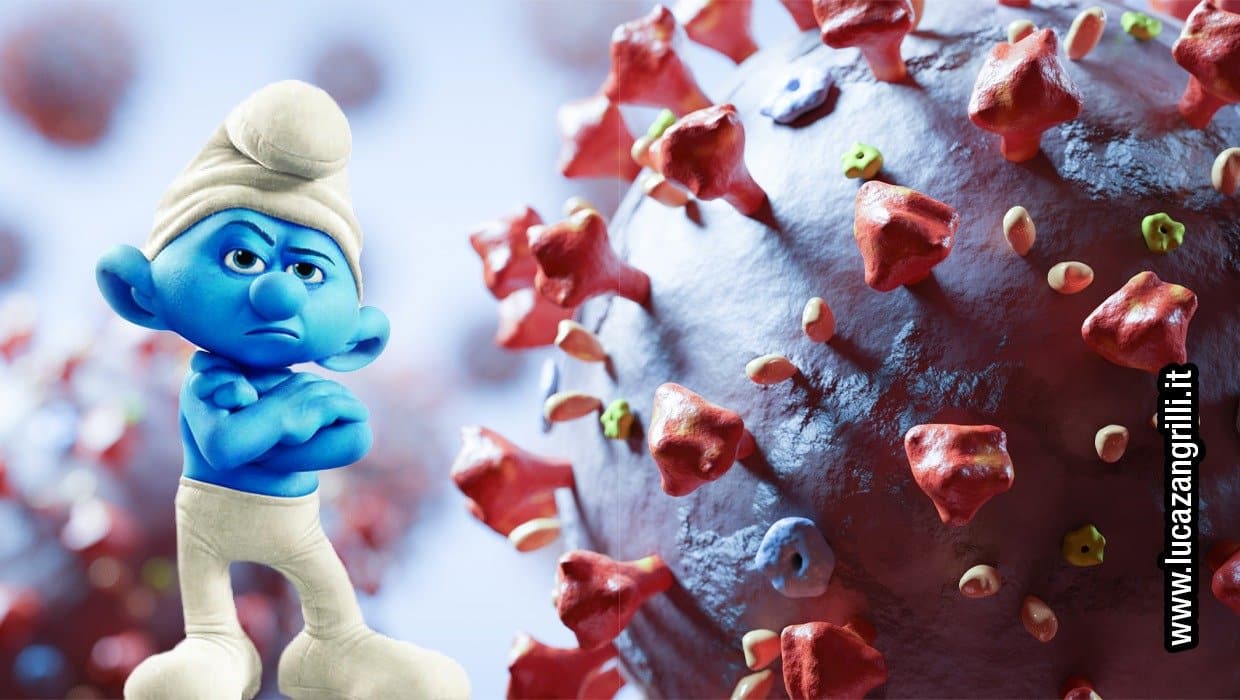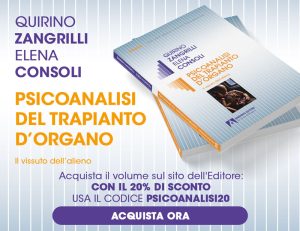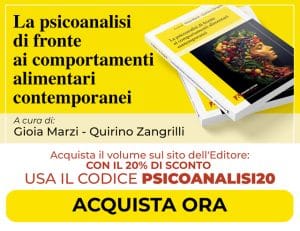Il tema del rapporto tra psicoanalisi e libertà è estremamente ampio ed è stato affrontato da molti psicoanalisti nei diversi ambiti: individuale, sociale e politico. Tra gli autori che hanno scritto su questo tema, ricordiamo Freud, Jung, Winnicott, Fromm.
Del resto, possiamo senza dubbio affermare che il desiderio di libertà ha sempre animato l’essere umano che lo ha espresso in modi diversi in funzione dei contesti, delle situazioni soggettive ed anche delle epoche storiche.
Gli esseri umani sperimentano spesso un conflitto fondamentale tra il desiderio di libertà (autonomia e autodeterminazione) e il desiderio di avere un legame. Sia la psicoanalisi classica che gli approcci contemporanei hanno esplorato come questo conflitto si manifesti nelle relazioni, plasmando i nostri desideri libidici, i modelli di attaccamento e persino le nostre scelte ripetitive.
Per affrontare in maniera sufficientemente obiettiva questo conflitto, è necessario tener conto di tanti fattori che possono concorrere al manifestarsi di opposte tendenze. In caso contrario, si rischia di emettere giudizi affrettati, condizionati da valori morali e culturali o anche dalla familiarità o estraneità con certe modalità espressive.
Per esempio, nelle società in cui da qualche generazione si è abituati ad un ruolo attivo della donna, assolutamente sovrapponibile a quello dell’uomo in ambito lavorativo e sociale, può sembrare inconcepibile che una donna si dedichi solo alla famiglia e alla cura dei figli. E risulta impossibile prendere in considerazione l’eventualità, seppur remota, di una sua libera scelta.
Io non mi occupo di fenomeni sociali e le mie riflessioni prendono spunto dalla clinica.
Ritengo, pertanto, che bisognerebbe mettersi d’accordo sull’accezione che diamo alla parola “libertà”. Di quale libertà parliamo? Freud aveva sottolineato quanto i gradienti di libertà siano condizionati da componenti che sfuggono al desiderio conscio e non dipendono, se non in parte, dal desiderio dell’uomo di essere libero. Quindi, indipendentemente dalla sua volontà l’uomo è soggetto ai vincoli costituiti dai traumi infantili, dalle fissazioni libidiche, dalla rigidità delle istanze psichiche, dai meccanismi difensivi e dai condizionamenti familiari.
La rigidità degli schemi difensivi rendono la struttura dell’Io poco plastica e pertanto facilmente esposta a rotture. In questi casi, ciò che osserviamo nel corso del lavoro psicoanalitico è un alternarsi tra stati di relativo benessere e fasi di riacutizzazione della sofferenza somatopsichica. Queste oscillazioni corrispondono ad espressioni di maggiore libertà nelle associazioni verbali, facilità di accesso alle emozioni, apertura nei confronti della relazione, in contrasto con fasi di chiusura a causa della riattualizzazione del trauma con tutto il corollario delle manifestazioni sintomatiche e difensive.
Per attenermi al tema della discussione odierna, ho scelto di parlare del conflitto tra il desiderio di essere liberi e quello di avere un legame, con specifico riferimento alle relazioni amorose.
Non a caso prima ho portato l’esempio della condizione della donna, perché è molto più frequente che siano le donne ad esprimere questo conflitto, senza nulla togliere ai rapporti di dipendenza in cui anche gli uomini spesso sono incastrati. Ma la donna ha alcuni vincoli in più, costituiti dalla sua struttura biologica. Ad esempio, nella donna questo conflitto si acutizza quando si avvicinano certi anniversari che la pongono a confronto con le scadenze dell’età fertile e di conseguenza di fronte alla scelta tra la costruzione della famiglia e l’investimento nella carriera.
Un conflitto riassunto da Freud nella prima topica tra pulsioni sessuali o di conservazione della specie e pulsioni dell’Io o narcisistiche. Una concettualizzazione che non ha mai perso di validità, neppure dopo la formulazione della seconda topica. Certamente, un conflitto meno presente nel sesso maschile, anche nelle nuove generazioni, in cui il maschio è molto più coinvolto nel ruolo di accudimento della prole. Ciò a dimostrazione di quanto resti primario l’impegno della donna nella riproduzione. Un impegno fisico, quello della donna, cioè biologico oltre che psichico, che ha inizio con la gestazione e coinvolge madre e figlio per molti anni, essendo la nostra specie a lungo inadatta all’autonomia. Per non parlare del legame psichico madre-figlio che, come sappiamo, può durare molto a lungo, almeno fino allo spostamento dell’investimento libidico su un oggetto sostitutivo. Ed è proprio la pulsione sessuale, cioè la spinta alla riproduzione (S. Fanti, 1984, parlava di spinta all’autoriproduzione ) che attiva la ripetizione, o forse sarebbe più chiaro dire, la continuazione del legame, innanzitutto con il figlio, ma in prima istanza con il partner “scelto” per la procreazione. Certo, tale affermazione oggi è confutata dai progressi della medicina che consente di bypassare la scelta di un partner per riprodursi: oggi la donna può recarsi alla banca del seme per poter avere un figlio. Per il maschio non è la stessa cosa: seppur in assenza di coito, il maschio, per riprodursi ha bisogno, almeno fino ad oggi, del legame con una femmina disposta a portare in grembo suo figlio.
Del resto, ricordiamo che per Freud la pulsione ha sempre una base biologica. Lo scopo della pulsione è l’abbassamento della tensione nell’organo che è al contempo fonte del bisogno-desiderio. Tale scopo è ottenuto attraverso il raggiungimento dell’oggetto sul quale avviene la scarica. Quindi oggetto e meta della pulsione coincidono. In questo senso la teoria freudiana delle pulsioni è, incontrovertibilmente, una teoria delle relazioni oggettuali. Senonché Freud aggiunge che l’oggetto della pulsione può essere anche il proprio corpo o una parte di esso e persino una fantasia. In questo caso, nel conflitto tra libertà e legame prevale l’investimento narcisistico sul proprio Io. “Una persona che ama – scriveva Freud – ha rinunciato a parte del suo narcisismo” (Freud s: 1914). In altre parole, dedicare la libido a un oggetto d’amore esterno diminuisce la concentrazione su se stessi, creando una vulnerabilità che può essere ripristinata solo dall’essere ricambiati nell’amore.
Negli scritti successivi al 1920 con la formulazione della seconda teoria delle pulsioni Freud affronta le manifestazioni del conflitto tra bisogno di legame e bisogno di libertà dal punto di vista della coazione a ripetere. Egli osserva che i pazienti, per effetto di esperienze traumatiche infantili, a volte ripetono schemi relazionali dolorosi invece di ricercare il piacere. I post freudiani, a partire da Winnicott, sottolinearono l’importanza delle relazioni oggettuali, fin dalle esperienze precoci con il cargiver che influenzano l’oscillazione tra autonomia e dipendenza nelle relazioni future. Nei primi anni di vita il bambino acquisisce progressivamente la sicurezza in se stesso, la capacità di stare solo, giocando in presenza di una persona di cui si può fidare, realizzando gradualmente di essere separato, ma al contempo legato in modo sicuro. In termini adulti, significa che una persona può sentirsi autonoma e “sola” anche in una relazione, perché porta con sé una sicurezza interiore derivante da un attaccamento precoce rassicurante.( Winnicott D., 1958) Winnicott ha illustrato questo concetto con uno scenario vivido: dopo un’esperienza condivisa appagante (come l’intimità sessuale), ciascun partner dovrebbe essere in grado di stare da solo, appagato dalla presenza dell’altro. Winnicott scrive: “Poter godere della solitudine insieme a un’altra persona che è anche sola è di per sé un’esperienza di salute”. (ibidem pag.30). In una coppia affettuosa, ognuno può ritirarsi temporaneamente in se stesso senza che l’altro si senta abbandonato; c’è una fiducia reciproca che la vicinanza riprenderà senza timori eccessivi. Se uno dei due partner non possiede questa capacità, la relazione può diventare soffocante o instabile – ad esempio, uno dei due si aggrappa o richiede continue rassicurazioni, mentre l’altro si sente soffocato e desidera ardentemente la fuga. Winnicott fa risalire tali modelli alle prime fasi dello sviluppo. Ad esempio, se i tentativi di separazione di un bambino piccolo vengono accolti con ansia o incoerenza dalla madre, il bambino potrebbe non raggiungere pienamente un senso di sé stabile, separato dagli altri. In età adulta, quell’individuo potrebbe vivere l’intimità come una perdita di sé e difendere strenuamente la propria libertà, o al contrario vivere qualsiasi indipendenza come un terrificante abbandono e aggrapparsi disperatamente al partner.
Nell’esperienza clinica troviamo riscontro di quanto questo confitto sia quotidianamente presente nelle relazioni amorose.
Nei paesi occidentali più attenti alle problematiche sociali e alla violenza in ambito domestico, si sono diffuse comunità di accoglienza per i bambini accompagnati dalle loro mamme, se consenzienti. Gli operatori di comunità, ai quali il Tribunale per i minori chiede di osservare le capacità genitoriali delle mamme, riportano frequentemente che, dopo un periodo iniziale in cui le donne sono grate per essere state sottratte assieme ai loro figli alle angherie di un marito violento, magari dedito all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, cercano nuovamente il contatto con il marito. Queste donne mostrano di non avere nessuna consapevolezza delle ripercussioni che la contraddizione del loro comportamento avrà sui figli. Possiamo affermare che il legame con il partner è primario rispetto a quello con i figli. Inoltre nel caso di relazioni che comportano rischi per l’incolumità psichica e fisica, è particolarmente evidente il conflitto tra libertà e legame. In questi casi l’atto riproduttivo si riduce alla necessità biologica che non implica l’esistenza del legame con il figlio, l’assunzione di responsabilità rispetto al suo benessere, la sua crescita ed il suo futuro. L’atto riproduttivo risponde al desiderio narcisistico di colmare il vuoto causato dall’assenza di una vera relazione oggettuale e al contempo il mezzo per ottenere benefici secondari: il mantenimento da parte del padre o dello Stato.
Ma non tutti i casi sono così estremi e ciononostante, non manchiamo di riscontrare il conflitto anche in situazioni apparentemente molto distanti da quella appena descritta.
Come già detto, certi anniversari, soprattutto per le donne, possono essere particolarmente dolorosi e provocare l’attivazione di stati sintomatici inspiegabili, che si chiariscono solo grazie al lavoro associativo in cui emerge il conflitto di cui ci stiamo occupando.
Giulia aveva interrotto la terapia un anno prima perché non ne sentiva più bisogno, ma ora sta per compiere 30 anni e sta male: soffre di stati d’ansia, disturbi del sonno, ha perso peso. In questo anno ha ottenuto grandi successi lavorativi, si è sentita molto più sicura di sé, è aumentata l’autostima. Ha ottenuto una gratifica professionale e tra qualche mese si trasferirà in un altro paese dove le si apriranno grandi prospettive di carriera. In contrasto con tutto ciò, la relazione con il suo fidanzato è diventata noiosa. Spesso vorrebbe stare da sola, avere più spazio per se stessa, non sopporta più gli sbalzi di umore di lui e persino i rapporti sessuali si sono rarefatti. Parla con invidia di un’amica che è partita da sola per una lunga trasferta di lavoro.
A dispetto di tutto quanto detto, l’idea di separarsi dal suo fidanzato la atterrisce; ha sempre pensato che lui fosse l’uomo con il quale avrebbe costruito la famiglia, ma ora il desiderio si è spostato sul polo narcisistico: non è certo il desiderio di maternità ad essere prevalente, bensì la realizzazione personale. E’ possibile che si tratti di un’oscillazione transitoria, che tra qualche anno la pulsione sessuale torni ad investire l’attuale fidanzato e che la coppia si trasformi un una famiglia. Difficile pronosticarlo.
Conclusioni
Il tema del conflitto tra bisogno di attaccamento e bisogno di libertà è stato al centro del dibattito psicoanalitico dal suo nascere e sebbene ad un primo sguardo appaiano grandi divergenze tra i diversi autori (Freud, Winnicott, Fromm), mi pare di poter dire che ci siano più punti in comune che disaccordi. L’essenza consiste nel fatto che il conflitto esiste nell’uomo fin dall’inizio della vita e lo accompagna nel percorso di autonomizzazione dagli oggetti di attaccamento. Inoltre, il concetto freudiano di pulsione contempla in sé il legame, in quanto implica un movimento per il raggiungimento dell’oggetto. In caso contrario, cioè se la libido non si sposta dal luogo di propagazione agli oggetti del mondo esterno, l’individuo è “congelato”. Infine, non dobbiamo dimenticare che la pulsione sessuale, che ha come scopo ultimo la riproduzione, contiene in sé il concetto di legame. Infatti nella nostra specie, che non si riproduce per partenogenesi, le due cellule sessuali (ovulo e spermatozoo) devono muoversi, incontrarsi ed unirsi/legarsi per garantire la continuazione della specie.
E’ possibile che la tendenza attuale al narcisismo e cioè alle difficoltà di legame sufficientemente stabile con l’oggetto, sia una delle cause del calo demografico in molti paesi ad economia avanzata.
Bibliografia:
Freud S. (1914) Introduzione al narcisismo in Opere Vol.7 B. Boringhieri
Freud S. (1920) Al di la del principio del piacere in Opere Vol.9 B. Boringhieri
Freud S. (1915) Pulsioni e loro destini in Opere Vol.8 B. Boringhieri
Fanti S. (1984) Dizionario di psicoanalisi e micropsicoanalisi, Borla
Winnicott D. (1958) Sviluppo affettivo e ambiente, Armando
© Bruna Marzi
Responsabile scientifico di Micropsy.academy, piattaforma per l’aggiornamento professionale di psicologi, psicoterapeuti, medici e psichiatri. E’ perito presso il Tribunale Civile di Bergamo. E’ autrice di numerose pubblicazioni presentate a Congressi nazionali ed internazionali. Curatore e co-autore di 4 libri in lingua russa. Possiede un’ottima conoscenza parlata e scritta dell’inglese e del russo.
————
Born in Frosinone on 01.13.1958. Graduated in Psychology at “La Sapienza” University of Rome. She carried out psychoanalytic training in Turin and Switzerland. Member of Italian Psychologists Association since its constitution in 1990 (n.5482). Member of the International Society of Micropsychoanalysis and training analyst of Swiss Institute of Micropsychoanalysis. Main lecturer of the module “Micropsychoanalysis” in the Postgraduation programme of “Psychoanalysis, psychoanalytical psychotherapy and psychoanalytical consultation” at Moscow Institute of Psychoanalysis. She works in Bergamo and Moscow, where she practices psychoanalysis and psychotherapy in Italian, Russian and English with people of different nationalities. She has extended experience on psychotherapy of battered and sexually abused women. She’s trainer and supervisor of several Hosting Communities for children and women and leads master classes for postgraduate psychologists in Italy and Russia. Scientific manager of training platform Micropsy.academy. Expert of the Court of Bergamo: Author of several scientific publications presented at National and International Congresses. She’s fluent in English and Russian languages.
————
Доктор психологии – психотерапевт – психоаналитик. Закончила психологический факультет римского университета «La Sapienza». Далее специализировалась в
микропсихоанализе и микропсихоаналистической психотерапии в Турине и в Швейцарии под руководством Проф. Н. Пелуффо. Зачислена в Орден психологов с самого его основания в 1990 (No 5482). Действительный член Международного общества микропсихоанализа, тренинговый психоаналитик Швейцарского института микропсихоанализа. Руководитель курса по микропсихоанализу в Московском институте психоанализа. Благодаря работе в области медицинских
и социальных услуг приобрела обширный опыт в случаях
психологического, физического и сексуального насилия по отношению к детям и женщинам. Ведет преподавательскую деятельность и супервизии с психологами и психотерапевтами разных учреждений. Эксперт Судьи г. Бергамо. Научный руководитель обучающей платформы Micropsy.academy. Является автором многих научных докладов и статей, представленных как на национальных, так и на международных Конгрессах. Хорошо владеет английским и русским языками.