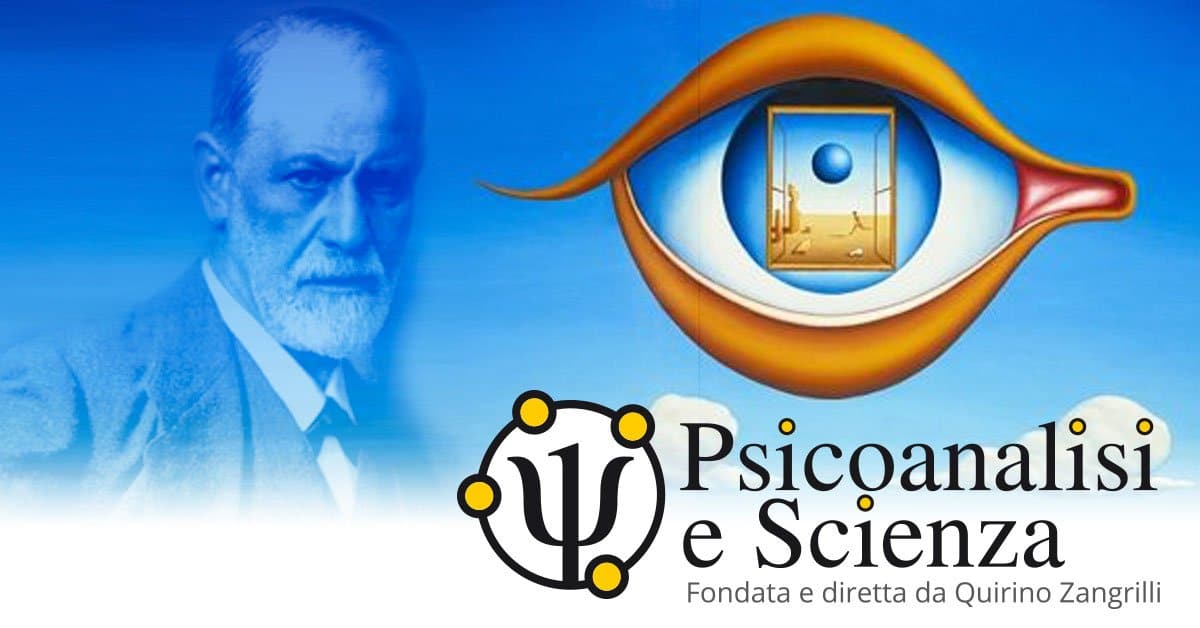Microdinamica del transfert
Il presente lavoro è comparso sul n° 4 del Bollettino dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi
Primo semestre 1987.
Nella storia del movimento psicoanalitico probabilmente nessun concetto ha subito una evoluzione così complessa e profonda come quello di transfert. All’inizio il transfert è per Freud soltanto una forma di spostamento dell’affetto da una rappresentazione mentale ad un’altra, e la preferenza per lo schermo costituito dall’analista è dovuta al fatto che esso costituisce una specie di “resto diurno” sempre a disposizione del soggetto e che questo tipo di trasferimento favorisce la resistenza in quanto l’esplicitare il desiderio rimosso è reso più difficile se deve essere fatto all’interessato.
Come si vede, si concepisce il transfert essenzialmente come resistenza tendente a nascondere la vera natura delle fantasie infantili proiettate sull’analista (S.Freud, ”Studi sull’isteria”, 1893-95).
Il successivo sviluppo del pensiero freudiano si allontanerà, per approfondirsi, da questa prima formulazione. Passando per le teorizzazioni raccolte ne “La dinamica del transfert” del 1912, in cui si parlerà per la prima volta esplicitamente di investimento libidico di “prototipi infantili”, “clichés indeformabili” esistenti nel soggetto, si perviene alla concezione, essenzialmente energetica, esplicitata in “Al di là del principio del piacere” (1920) in cui Freud riconduce il transfert a quella tendenza generale della materia vivente a ricostituire per ripetizione gli eventi traumatici nel fine onnipotente di accedere alla stasi pretraumatica.
Ho riportato succintamente tale sviluppo poiché molti psicoanalisti mostrano nelle loro teorizzazioni e nei loro rendiconti clinici di essersi appiattiti sulla iniziale formulazione freudiana, probabilmente perché più consona ad una visione onnipotente dell’impresa psicoanalitica.Ritengo che affermazioni, piuttosto frequenti, come “attivare”, ”creare”, ”manipolare il transfert” siano la cartina al tornasole di tale visione riduzionistica che porta ad una pericolosa sottovalutazione del fenomeno.
Se solo si pensa alle difficoltà che normalmente si incontrano per ricondurre all’osservazione analitica i nuclei infantili dislocati nel presente e attualizzati, ad esempio, in un rapporto amoroso con il partner, si potrebbe facilmente rendersi conto che nulla, di quanto già non sia in nuce tra l’analista e l’analizzato, si crea nel rapporto analitico. E ciò che si crea, per lo meno finché la dinamica transferale non sia stata portata alla coscienza e sufficientemente metabolizzata, è totalmente condizionato dalle immagini filogenetiche racchiuse nel corredo ideico dei due soggetti in interazione.
Come esplicita con chiarezza N.Peluffo in “Immagine e fotografia” (1984) “la relazione con l’oggetto è sempre interna e sotto la pressione dello stimolo esterno una delle sfaccettature ( affetto e rappresentazione ) di tale relazione viene proiettata all’esterno e dà l’intonazione affettiva alla situazione dei rapporti di vita quotidiana ( vedi ciò che succede nel transfert )”.
Cosa altro avrebbe potuto intendere Freud quando, sempre ne “La dinamica del transfert” afferma:“quando tutto il materiale composito nell’ambito del complesso è idoneo ad essere trasferito sulla figura del medico, tale transfert ha luogo”, se non che si è raggiunta, per intervento del caso o del tentativo, una omogeneità tra le immagini attivate nella psiche dei due soggetti in relazione?
Alla luce di queste considerazioni si comprende perché Silvio Fanti insista nel riaffermare l’idea che “tutto ciò che indichiamo con il termine di transfert è inconscio” (Comunicazione personale, 1987), cioè per sottolineare che noi siamo vissuti dalle dinamiche transferali delle immagini psichiche e la possibile elaborazione cosciente di tale dinamica può essere fatta solo a posteriori.
D’altra parte già Jung aveva compendiato l’essenziale di questi aspetti ne “La psicologia del transfert” (1946): “Nell’atto in cui il paziente trasferisce sul medico, mediante l’azione induttiva che si sprigiona sempre, in misura maggiore o minore, dalle proiezioni, un contenuto attivato dall’inconscio, viene costellato anche nel medico il materiale inconscio corrispondente. In tale modo medico e paziente si trovano in un rapporto fondato su una comune inconscietà”.
Ora lo scopo del lavoro psicoanalitico e particolarmente di quello micropsicoanalitico, e la modalità stessa con cui di fatto si realizza, è quello della osservazione delle dinamiche ripetitive fino alla messa a nudo, e possibilmente alla abreazione energetica, del nucleo originato dal trauma, che determina la forma psicomateriale che tende a riprodursi nel presente con modalità che sono del tutto identiche a quelle che aveva nel momento in cui l’accumulo energetico ha avuto luogo (N.Peluffo, “La situazione”, Bollettino n° 5 ).
Finché il lavoro di revisione del rimosso viene condotto su vicende ontogenetiche relativamente recenti (inerenti agli stadi fallico ed anale) di solito non sono necessari particolari accorgimenti; anche se, ad esempio, per riattivazione di situazioni traumatiche proprie dello stadio fallico si possono determinare delle spinte all’autocastrazione punitiva talmente potenti da poter determinare incidenti autolesionistici più o meno seri. (Una volta per tutte converrà ricordare che non sempre è possibile, soprattutto in casi particolarmente gravi, vincolare il paziente al ricordo e all’elaborazione, piuttosto che all’agire!).
Quando, invece, si riattivino dinamiche che competono lo stadio orale e quello iniziatico, la vigilanza del micropsicoanalista deve essere portata al massimo livello in quanto, come ha dichiaratamente mostrato N.Peluffo ne “La situazione”, nel momento in cui tali dinamiche fusionali si riattivano possono innescare dei meccanismi difensivi disastrosi che possono mettere persino in pericolo la vita del soggetto.
Vorrei ora ampliare il discorso per entrare in una prospettiva filogenetica; per farlo vorrei descrivere quella che ritengo una vera e propria stigmate sintomatica che ho costantemente ritrovato nei pazienti psicotici o border-line da me trattati. Quando l’analisi si approfondisce fino alla messa a nudo dei nuclei conflittuali ontogenetici ho riscontrato nel materiale, in forma di sogno o nel corso del lavoro associativo, l’apparizione del fenomeno seguente: il paziente inizia con il dire che sta per verbalizzare l’essenza dell’incubo della sua esistenza e descrive l’avvicinarsi di un mostro, un diavolo che si tenta in tutti i modi di tenere a distanza. “E’ come se ruotassimo sui cardini di una porta: io cerco di mantenermi a distanza ma viene il momento in cui lui si avvicina, avvicina sempre di più, ed io sono presa da un orrore senza fine e dalla voglia di uccidere, uccidere per liberarmi, uccidermi per liberarmi. Se un giorno riuscissi a spezzare questo cerchio sarei guarita per sempre”.(giovane donna portatrice di una sindrome grave a sfondo paranoico). In questa sede non mi interessa interpretare il materiale fornito quanto sottolineare che sono sempre stato colpito da questa dinamica circolare, da questo elementare tentativo di fuga. Ribadisco che, sistematicamente, il fenomeno viene descritto in questi termini.
Associativamente il fenomeno mi richiama il Riflesso di Moro che ho visto manifestarsi alla nascita tante volte nei neonati che ho osservato nel corso della mia esperienza medica: in risposta ad uno stimolo che può essere un colpo portato sul piano d’appoggio su cui si trova il neonato, questi ha un sobbalzo, abduce le braccia allargando le dita a ventaglio, poi le flette e adduce con caratteristico atto di abbracciamento, descrivendo un arco in aria. “E’ la risposta di Moro, un residuo “primitivo” di qualcosa che appartiene al nostro lontano passato, un “riflesso” che non ha oggi alcuna utilità e che, in capo a poche settimane, sparirà nelle nebbie confuse delle nostre origini biologiche” (R. Restak, Il cervello del bambino, 1986).
Ritengo che il Riflesso di Moro sia l’espresssione di un riflesso avversativo di difesa che esprime un duplice tentativo: allontanarsi dallo stimolo e, contemporaneamente, chiudersi nella propria sfera microcosmica; l’equivalente somatico di quel desiderio inconscio di “ritorno ad una forma anulare che esaurisca in sé il cosmo” che N. Peluffo mette in luce in “Micropsicoanalisi dei processi di trasformazione” (1976).
Ma torniamo alla dinamica psichica descritta che denomino “movimento ciclico dell’immagine persecutoria”. In sostanza si tratta della ripresentazione dell’immagine del trauma che, si badi bene, può essere attivata da qualsiasi situazione transferale che, eludendo le fragili difese dell’Io smembrato dello psicotico, determini una penetrazione traumatica dell’oggetto (l’analista, il partner, il gruppo, etc.) nell’universo fusionale materno-fetale cui lo psicotico è fissato.
Da questo punto di vista, ad esempio, se è pur vero che ad un certo livello della strutturazione psicosessuale la posizione paranoica risulta essere una difesa contro l’emergenza di impulsi omosessuali negati, a livello del terreno psichico essa è il precipitato filogenetico del fallimento di tentativi transgenerazionali di permettere l’ingresso dell’Altro nel rapporto fusionale. A questo punto converrà tenere presente che il transfert, oltre a riattivare le immagini infantili, uterine e filogenetiche, riattiva i medesimi tentativi di difesa che furono messi in atto in origine. Si può ipotizzare (e a volte riscontrare) che nel patrimonio genealogico di questi soggetti si siano effettivamente determinate delle situazioni traumatiche che, potendo determinare la distruzione dell’individuo, evocassero delle risposte difensive che contemplavano la necessità di uccidere. Una risposta che, a livello dell’es, per essere chiari, si riscontra nella mente del soggetto normale ogni qual volta l’Immagine filogenetica si manifesti con la forza spaventosa del suo silenzio. Ovviamente i meccanismi difensivi dell’io modulano la risposta e la elaborano, con il prezzo di un irrigidimento degli schermi iconici e della struttura caratteriale. Allo psicotico, che non dispone di queste risposte “superiori”, non rimane che il passaggio all’atto o, più spesso, la fuga, il ritiro narcisistico della libido dalla realtà e il diniego. Sembra quindi che nello psicotico l’equivalente psichico del riflesso di Moro non scompaia per lasciare il passo a processi difensivi meno drammatici.
Se la micropsicoanalisi del nevrotico ha tra i suoi scopi fondamentali quello di rendere più plastiche le strutture difensive che entrano in attività nella relazione con l’Immagine, il “lavoro di addomesticamento della statua”, di cui parla N. Peluffo in “Immagine e fotografia”, il lavoro micropsicoanalitico con psicotici ha come primo punto di approdo di rendere possibile questo contatto con l’immagine senza che esso determini dei cataclismatici riflessi filogenetici che la situazione ambientale non tollera più: in altri termini se il nevrotico deve arrivare a familiarizzarsi con la Statua, lo psicotico dovrà prima sopportarne la presenza.
Ora, la strada perché questo avvenga, passa, nel caso dello psicotico più che del nevrotico, nel transfert. Cioè il paziente ha il bisogno di rivivere la situazione originaria, inserendo, come vissuti, gli elementi di novità. Freud, con la consueta efficacia scrive: ”…in ultima analisi, è impossibile distruggere chicchessia in absentia o in effige”, e “Le sorti di ogni conflitto andranno risolte nella sfera del transfert”.
Per meglio illustrare questa dinamica mi servirò della breve esposizione di un caso clinico. Si tratta di un soggetto affetto da depressione anaclitica secondo R. Spitz, susseguente all’allontanamento coatto e poi alla scomparsa della madre avvenuta in tenera età, difesa parzialmente da una posizione psicotica di diniego del trauma e da un continuo, fallimentare e doloroso tentativo di stabilire un rapporto d’amore con una giovane donna che rappresentava a tratti per il paziente la reincarnazione della madre scomparsa. In una fase avanzata del trattamento il paziente intraprese più volte il tentativo di confrontarsi con la perdita negata, abreagirne l’angoscia legata al contatto con il vuoto e trovare delle forme di esistenza possibili nella nuova situazione in cui l’oggetto originario non era più presente, tentativi che culminarono con la visita dei luoghi dell’infanzia che incluse anche la visita del cimitero dove la madre era sepolta. L’ausilio dell’io dell’analista, insieme al rafforzamento dei processi di elaborazione che il giovane aveva conseguito nel lungo lavoro analitico condotto fino a quel momento, determinò per la prima volta la presa di coscienza dell’accaduto ed innescò una elaborazione, certamente lacerante e dolorosa, ma vitale, del lutto.
Quello che è interessante è che, nell’intervallo tra una seduta e l’altra di questa tranche, vidi il giovane paziente presentarsi nel mio studio in preda all’agitazione più profonda perché, avendo incontrato di nuovo l’amata, l’aveva vista come uno zoombie, un morto vivente che lo atterriva.
La fase di elaborazione della presa di coscienza della morte della madre aveva avuto il bisogno imperioso di trasferirsi nel presente per consumarsi come evento vissuto e solo il lavoro di abreazione dell’affetto dislocato sulla situazione persecutoria attuale, ebbe la possibilità di esaurire l’investimento energetico sull’immagine materna e favorirne il distacco. E’ questo un fenomeno che, se pur con intensità proporzionalmente ridotta, si verifica anche nei nevrotici e nei soggetti normali. Si creano , cioè, delle vere e proprie sacche esistenziali in cui l’accumulo energetico utero-infantile si disloca ed è solo mettendo in atto l’accortezza tecnica di vincolare le associazioni del paziente sulla situazione attuale, riducendo quel movimento sinusoidale tra presente e passato, che si può riuscire ad enucleare l’affetto incistato nella situazione transferale
Nel 2024 riceve il Premio Accademico d’Onore della Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0.
Nel 2024 docente ad Almaty – Kazakhstan presso il workshop di psicoanalisi sul tema della violenza, promosso dall’Università di psicoanalisi di Mosca in collaborazione con l’Istituto svizzero di micropsicoanalisi.
Doctor Quirino Zangrilli was born in Fiuggi in 1955. Graduated with honours in Medicine and Surgery in 1980, he practices Psychoanalysis, with intensive method, since 1982. He is author of 72 scientific pubblications. He has attended as speaker or president of session to many national and international scientific Conventions. His book “La vita:involucro vuoto” (Life: empty involucre), published by Borla in 1993, has been in use by the Chair of Dynamic Psychology at Turin’s University since 1994. He is the author and founder of the multimedia review “Psicoanalisi e Scienza” (Psychoanalysis and Science), the most read Italian on line review of psychoanalysis. In 2012 he participated as a Speaker at the Scientific Festival of BergamoScienza. In 2013 he illustrated his research on the maternal-fetal interaction in the Special Session of the XI World Congress of Perinatal Medicine in Moscow with his relation “Intrauterine Imprinting”. He is visiting teacher at Moscow Institute of psychoanalysis and training psychoanalist of Swiss Institute of Micropsychoanalysis.
In 2024 he is a teacher in Almaty – Kazakhstan at the psychoanalysis workshop on the topic of violence, promoted by the Moscow University of Psychoanalysis in collaboration with the Swiss Institute of Micropsychoanalysis.
In 2024 he received the Honorary Academic Award of the Carthage 2.0 International Cultural Academy
Le Le Docteur Quirino Zangrilli est né à Fiuggi en 1955. Diplômé avec mention en Médecine et Chirurgie en 1980, il pratique la psychanalyse depuis 1982, en utilisant une technique intensive. Il est l’auteur de 72 livres et publications scientifiques. Il a participé en tant que conférencier ou président de session à de nombreuses conférences scientifiques nationales et internationales. Son livre “La vie : enveloppe vide”, publié par Borla en 1993, est adopté depuis 1994 par la Chaire de Psychologie Dynamique de l’Université de Turin. En 1994, il a reçu le “Prix national Ciociaria de médecine”. Il a conçu et fondé le magazine multimédia “Psicoanalisi e Scienza”, qui est le magazine de psychanalyse en ligne en italien le plus suivi au monde. (Source : Entireweb, Alexa, Google, Virgilio, Arianna., etc.). En 2012, il a participé en tant que conférencier à la colloque scientifique de BergamoScienza. En 2013, il a exposé ses études sur l’interaction materno-fœtale lors de la session spéciale du XIe Congrès mondial de médecine périnatale à Moscou avec le rapport “Intrauterine Imprinting”. Il est chargé d’enseignement au cours de spécialisation de trois ans en psychanalyse, psychothérapie psychanalytique et consultation psychanalytique à l’Université de Moscou. Il est membre didacticien de l’Institut Suisse de Micropsychanalyse et de la Commission pour la Pratique de celui-ci.
En 2024, il enseigne à Almaty – Kazakhstan à l’atelier de psychanalyse sur le thème de la violence, promu par l’Université de Psychanalyse de Moscou en collaboration avec l’Institut Suisse de Micropsychanalyse.
En 2024, il reçoit le Prix Académique Honoraire de l’Académie Culturelle Internationale Carthage 2.0.
В 2024 году является преподавателем в Алматы – Казахстан на семинаре по психоанализу на тему насилия, проводимом Московским университетом психоанализа в сотрудничестве со Швейцарским институтом микропсихоанализа.
В 2024 был награжден Почетной академической премией Академии Международной Культуры «Карфаген 2.0».